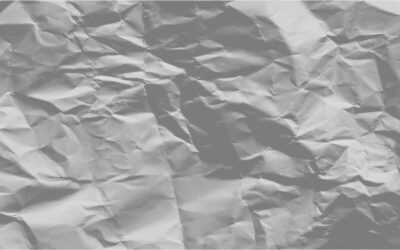Secondo il pilastro “societas delinquere non potest”, una persona giuridica non poteva rispondere di un reato. Ma questo principio è stato ribaltato visto il frequente aumento dei reati commessi nelle imprese.
Per questo nel 2000 il Parlamento ha approvato la legge di delegazione n. 300, la quale ha portato poi al D.lgs. 231/2001, senza però spingersi fino ad attribuire una vera e propria responsabilità penale in capo all’ente al pari delle persone fisiche, bensì una responsabilità amministrativa conseguente al reato totalmente autonoma rispetto a quella del suo autore e vincolata, come vedremo, alla sussistenza di una serie di condizioni tassativamente previste.
In primo luogo, si rende necessario precisare che il D.lgs. 231/2001 si applica agli enti dotati di personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Sono invece esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici strumentali e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Ora, premesso l’ambito di applicazione, cos’è che determina la responsabilità da reato dell’ente?
Innanzi tutto, come condizione preliminare, è necessario che sia stato commesso uno dei c.d. reati presupposto individuati agli artt. 24 e seguenti del D.lgs 231/2001, ossia condotte penalmente rilevanti e tassativamente previste dalla normativa.
L’eventuale commissione di reati diversi, quindi, comporterebbe l’esclusiva responsabilità penale dell’autore.
In seconda battuta interviene il criterio oggettivo di imputazione, il quale stabilisce che l’ente è responsabile per i reati previsti agli artt. 24 e seguenti soltanto se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone appartenenti alla sua struttura organizzativa.
Inoltre, bisogna fare un distinguo, per queste due tiplogie di persone fisiche.
Se il reato è commesso da persone in posizione apicale, per discolparsi l’ente dovrà dimostrare di aver adotatto un Modello organizzatoivo e di controllo efficace alla prevenzione dei reati, e che tale modello è sttao aggirato fraudolentemente, ossia con artifici e raggiri appositi, dal soggetto agente.
Qualora, invece, il reato venga commesso da soggetto in posizione di sottoposizione, allora la colpa organizzativa dell’ente è esclusa. Cosa significa? Significa che se il soggetto agente ha comemsso iuno dei reatoi presupposto e se ha violato il modello così come predisposto dall’ente, allora l’ente stesso è discolpato. In questo caso, non deve provare la concreta efficacia del modello di controllo adottato, perchè la sua colpa organizzativa non si presume.
Naturalmente, resta viva anche l’ipotesi di dimostrare, se del caso, che l’autore ha commesso il reato nel suo esclusivo interesse personale o nell’interesse di un terzo diverso dall’ente.
Il ruolo dell’ODV
Ora, occorre chiedersi se e come sarebbe configurabile una responsabilità dell’organismo di vigilanza (Odv) per la commissione di eventuali reati presupposto.
L’Organismo assume il compito di vigilare sulla corretta applicazione del modello organizzativo, analizzare i flussi informativi da parte dei soggetti destinatari dei protocolli di prevenzione previsti dal modello, verificare periodicamente la diffusione del modello tra i suoi destinatari, curare l’aggiornamento e l’implementazione dello stesso e comunicare eventuali falle o distorsioni nell’applicazione dei modelli organizzativi da parte dei destinatari.
Ciò significa che se l’Organismo dovesse rilevare anomalie o problematiche di funzionamento, potrebbe solo riferire all’organo amministrativo o dirigenziale, il quale avrà poi l’onere di intervenire di conseguenza.
Quindi l’organismo ha solo poteri propositivi, consultivi, istruttori e di impulso, ma è totalmente estraneo alle scelte gestionali dell’ente.
Proprio in virtù dell’assenza di un dettato normativo specifico in tal senso, non può configurarsi, in capo all’Organismo di Vigilanza, una posizione di garanzia idonea a fondare la responsabilità per omesso impedimento dell’evento lesivo ai sensi dell’art. 40. c.p.
Di recente, però, la giurisprudenza ha iniziato a far vacillare questa ricostruzione.
La sentenza n. 10748/2020 pronunciata dal Tribunale di Milano, nella quale è stato contestato all’Organismo di aver “sostanzialmente omesso i dovuti accertamenti funzionali alla prevenzione dei reati, indisturbatamente reiterati”, e ancora, di aver “assistito inerte agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d’atto, nella vorticosa spirale degli eventi che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe certamente scongiurato”.
In altri termini, dalla sentenza sembra emergere un vero rimprovero nei confronti dell’OdV per non aver impedito gli eventi lesivi, mettendo in dubbio quella posizione giurisprudenziale, in vero prevalente, secondo la quale l’organismo non può rispondere insieme all’ente per i reati delle persone fiscche, in quanto non ha una posizione di garanzia ex articolo 40 c.p.