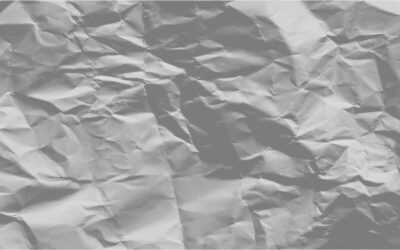CAPITOLO 1
L’AFFERMAZIONE DEL CONCETTO DI “AMBIENTE”
La definizione di “ambiente”
Le fonti nazionali e comunitarie non esprimevano una nozione generale e unitaria di ambiente. Sebbene molteplici siano le disposizioni legislative che contemplavano la tutela dell’ambiente e l’ambiente come valore fulcro delle politiche ambientali, mancava una definizione compiuta del suo significato. Nello specifico, la nozione di ambiente assumeva connotazioni differenti: una parte della dottrina lo considerava come “bellezza naturale e paesistica”, sul versante opposto veniva definito come categoria autonoma più complessa. Con l’articolo 9 Cost., emerge per la prima volta la tutela del concetto di “paesaggio”, concetto che poi l’interpretazione estensiva della giurisprudenza costituzionale ha ampliato intendendolo come “ambiente”. L’ambiente non aveva ancora una propria autonomia giuridica, ma era un “mero interesse” protetto soltanto via indiretta, ricevente tutela attraverso altri interessi di rango primario. In primo luogo, il perno giuridico della tutela ambientale era rappresentato dagli artt 844 e 890 c.c. Essi pongono un limite alla proprietà (844c.c) laddove si verifichi il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni nocive o un pericolo di danno alla salubrità (890c.c). Nel caso poi (comma secondo, art. 844 c.c.) che le immissioni provengano dallo svolgimento di un’attività produttiva e che esse superino la normale tollerabilità ai sensi del comma primo, spetta al giudice di contemperare mediante opportuni provvedimenti gli interessi della produzione con quelli della proprietà. All’infuori dei casi e dei limiti predetti tutte le altre immissioni sono ritenute illegittime e suscettibili di venire represse con l’azione negatoria (art.949 c.c.) oltre che mediante le azioni personali esperibili per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti. In seguito, la giurisprudenza iniziò ad elaborare l’impostazione secondo la quale l’interesse ambientale poteva ricevere tutela anche tramite il diritto alla salute. Nella sentenza 6 ottobre 1979, n. 5172, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano l’esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo alla salubrità dell’ambiente della comunità abitativa o di lavoro di cui il singolo fa parte, fondato sugli artt. 2 e 32 Cost. e azionabile dinanzi al giudice ordinario. La tutela dell’ambiente, dunque, concerne l’uomo non solo in quanto tale, ma in quanto partecipe delle varie comunità – familiare, abitativa, di lavoro, di studio ed altre – in cui vive e si relaziona.
La tutela dell’ambiente per il diritto dell’Unione
In origine la tutela dell’ambiente in ambito comunitario emerse quale interesse strumentale alla realizzazione dell’ obiettivo di politica comunitaria e di integrazione del mercato. L’ascesa del valore ambiente prosegue e trova consacrazione nel Trattato di Maastricht come “politica fondamentale” della Comunità. Gli obiettivi della politica ambientale europea vennero poi ulteriormente rafforzati e specificati nel Trattato di Amsterdam del 1997, che all’articolo 174 comma 1 li enuclea “nella salvaguardia, nella tutela e nel miglioramento della qualità ambientale.” La Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza nel 2000, stabilisce che “Un livello di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati dalle politiche dell’Unione.” Da ultimo il Trattato di Lisbona del 2009 ha modificato l’articolo 3 del TUE, dove si legge che l’Unione instaura un mercato interno e si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa. La CEDU non prevede espressamente il diritto ad un ambiente salubre, né prevede la tutela del diritto ambientale. Ciò nonostante la Corte di Strasburgo, attraverso un’interpretazione evolutiva delle disposizioni della Convenzione, estrapola la tutela del soggetto vittima dell’inquinamento, sul presupposto implicito dell’esistenza del diritto a vivere in un ambiente salubre. Così recita l’articolo 8 della CEDU: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.” Tale disposizione è studiata per proteggere l’ambiente; infatti, molte pronunce giudiziali della Corte qualificano l’inquinamento atmosferico e acustico come situazioni in grado di violare la vita privata e familiare.
CAPITOLO 2
LA RESPONSABILITA’ PER DANNO AMBIENTALE
Il concetto di danno ambientale
L’articolo 18 della legge 346/1986 si riferiva al danno ambientale ponendo attenzione alla condotta che compromette l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo e distruggendolo in tutto o in parte. Riprendendo alla lettera le indicazioni contenute nella direttiva 300/35 CE, invece, l’articolo 300 del codice dell’ambiente (dlgs 152/2006) stabilisce che è danno ambientale “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità associata a quest’ultima.” Il successivo comma 2 dell’articolo 300 prevede inoltre che “costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato a tre risorse tipiche (specie ed habitat naturali e protette; acque; terreni)”, prediligendo una nozione più restrittiva di danno ambientale rispetto a quella della legge 346/1986. Il codice sottopone alla disciplina del risarcimento per danno ambientale non tutti i soggetti, ma soltanto “l’operatore” definito come qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un’attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chiunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici o finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività. Sotto il profilo oggettivo, l’art 268 bs del codice dell’ambiente stabilisce che la disciplina della parte sesta del codice si applica al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5 della parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività; b) al danno ambientale causato da un’attività diversa da quelle elencate nell’allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo.
Il sistema delle tutele nel diritto ambientale
Il sistema delle tutele risarcitorie usa distinguere tre categorie: rimedi di natura restitutoria, rimedi di natura risarcitoria, rimedi di natura satisfattiva. Tali rimedi intervengono sempre in una fase ex post di commissione dell’illecito, e sono volte a riparare le conseguenze derivanti dalle violazioni commesse. Accanto a tali rimedi si fa sempre più pressante l’esigenza di misure volte a prevenire le violazioni o comunque ad attenuarne le conseguenze in presenza di beni fondamentali della vita che altrimenti si risolverebbero in pregiudizi irreparabili. La direttiva 2004/25 CE manifesta una chiara preferenza alle forme di tutela preventiva verso i pregiudizi che possono essere arrecati all’ambiente sulla base della considerazione che nella gran parte dei casi tali lesioni possono essere di natura irreversibile. Una volta verificatosi il danno, solo allora si prevedono misure ripristinatorie o riparatorie dirette a ristabilire lo stato originario della risorsa violata e, in un’ultima istanza, si prevedono meccanismi in forma specifica o per equivalente.
Il principio di prevenzione
Il principio di precauzione, quello di prevenzione, di correzione in via prioritaria ed alla fonte dei danni causati, di sviluppo sostenibile ed il “principio chi inquina paga”, costituiscono principi cardine del diritto all’ambiente. Oggi recepiti dal codice dell’ambiente all’articolo 3 bis. In ambito comunitario, il principio di precauzione è riconosciuto all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, oggi confluito nell’articolo 191, paragrafo 2, ed è stato recepito nel nostro ordinamento nell’articolo 301 del codice ambientale. Ai sensi dell’articolo 301, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. Una volta individuato il rischio per l’ambiente, l’operatore interessato è tenuto a porre in essere una serie di condotte informative alle Autorità competenti nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo nonché nel Prefetto della Provincia che nelle 24 ore successive, informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Informato del rischio e quindi del pericolo che l’ambiente corre, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare “ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 304.
Il principio di precauzione
Similmente al principio di precauzione opera il principio di prevenzione, che si sostanzia anch’esso in una serie di interventi anticipatori al verificarsi del danno ambientale. A differenza, però, del principio di precauzione, il principio di prevenzione opera in presenza di un “rischio ambientale” già conosciuto e scientificamente provato relativo a comportamenti o prodotti per i quali esiste al piena certezza circa la pericolosità per l’ambiente. L’articolo 304 del codice ambientale prevede che “quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro 24 ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza.
Il principio di correzione in via prioritaria ed alla fonte
Il principio di correzione in via prioritaria ed alla fonte dei danni causati non trova un’espressa definizione nell’ambito del codice ambientale, sebbene richiamato nell’art. 3 ter. La giurisprudenza comunitaria così lo interpreta: i danni causati all’ambiente vengono contrastati in una fase il più possibile vicino alla fonte per evitare che i loro effetti si amplifichino e si ingigantiscano. Un esempio pratico: in materia di inquinamento, al fine di realizzare la compatibilità ambientale con determinate attività inquinanti, si prevede la fissazione di limiti di concentrazione o emissione di sostanza al cui superamento l’ordinamento riconosce effetti diversi a seconda del tipo di limite valore. Negli standard di emissione il valore delle emissioni viene rilevato alla
fonte di inquinamento e pertanto tale misura risponde al principio di
correzione.
IL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA”
Come anticipato, la direttiva 200$/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce un quadro della responsabilità ambientale basato sul principio chi inquina paga. Il principio poi è stato elaborato, in sede internazionale, in due raccomandazioni OCSE del 1972 e del 1974, ed è stato introdotto nel tessuto europeo nel 1987 nell’ambito con l’Atto Unico europeo e oggi, previsto dall’art 191, par 2 TFUE, ne rappresenta il principio fondamentale in materia ambientale. La collettività, o comunque i soggetti non responsabili dell’inquinamento, erano costretti a sopportare costi che non venivano contabilizzati nel processo produttivo in caso di danno ambientale. Il principio del chi inquina paga trasferisce a carico dell’imprenditore i costi della produzione relativi all’ipotesi di danno ambientale. In tal modo, l’imprenditore è indotto a valutare nel miglior modo possibile i rischi ambientali derivanti dalla propria attività immettendo sul mercato prodotti economicamente più competitivi. Pertanto, il principio assolve ad una funzione sia preventiva sia preventiva, essendo volto a far rientrare i costi nell’ambito della contabilità d’impresa una volta che il danno si è verificato, un un’ottica risarcitoria una volta che il danno si è verificato.