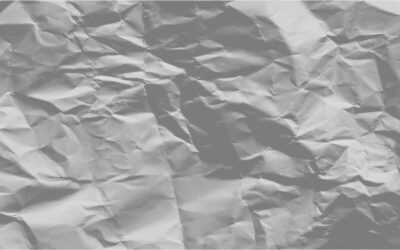La joint venture è una forma di associazione di imprese che mira alla collaborazione per la sopprtazione di sacrifici economici altimenti non sarebbero sostenibili.
Tra i motivi per cui vengono costituite le joint venture:
- l’esigenza dei partecipanti di condividere gli sforzi ed i costi di un’attività di ricerca e sviluppo;
- l’esigenza di ottimizzare un processo produttivo;
- l’esigenza di acquistare (congiuntamente) materie prime, scorte o servizi;
- l’esigenza di esplorare un nuovo territorio o mercato;
- l’esigenza di aggirare (attraverso la JV con un socio locale) normative che impongono tassazioni elevate agli investimenti stranieri;
2. Joint ventures contrattuali e societarie
Dal punto di vista tipologico le joint ventures si dividono in due fattJispecie: contrattuali e societarie. Le JV contrattuali soni accordi associativi atipici fra imprese, di tipo puramente contrattuale, solitamente utilizzate per raggiungere degli obiettivi preventivamente ben individuati e, il più delle volte, destinate a durare esclusivamente per il tempo necessario a raggiungere tali business targets (ad esempio la realizzazione di una grande opera, la partecipazione ad una gara di appalto internazionale, la distribuzione di beni fra l’esportatore e il concessionario-importatore locale, etc.).
Le JV societarie sono invece accordi tra due o più imprese per mezzo dei quali le stesse, al fine di raggiungere uno scopo comune prefissato, costituiscono una società autonoma e distinta rispetto ai singoli componenti. Nelle JV societarie, il veicolo della collaborazione è rappresentato da una società costituita “ad hoc” (newco), in cui i venturers sono azionisti o quotisti. Le JV societarie sono generalmente alla base di collaborazioni complesse e di più ampio respiro rispetto a quelle cui danno vira le JV contrattuali.
In ogni caso, i venturers, per il solo fatto di aver contratto una JV (contrattuale o societaria) non perdono la loro individualità giuridica ed economica; ciò significa che, parallelamente alla partecipazione alla JV, i singoli venturers continuano a svolgere autonomamente la propria attività finanziaria o produttiva.
Per tale motivo, nel contratto di JV uno dei profili più delicati è costituito dalla regolamentazione degli aspetti concorrenziali dell’attività propria della JV in relazione all’attività dei singoli venturers.
Spesso gli accordi di JV prevedono obblighi di non concorrenza durante la durata della JV. Le clausole di non concorrenza inserite nell’accordo principale sono generalmente finalizzate non già a limitare la concorrenza tra i venturers nei rispettivi mercati, bensì a limitare la concorrenza dei ventures con la JV da loro costituita. Tali limitazioni possono essere previste per determinate categorie di prodotti oppure per determinate aree geografiche.
Tali divieti possono assumere una varietà di contenuti. Ad esempio può essere previsto:
- un divieto per i venturers di svolgere attività rientrante nella stessa area di business della JV, riservando tutte le attività alla JV;
- un divieto per i venturers di competere direttamente con una determinata attività della JV;
- l’obbligo dei venturers di non sollecitare affari, o fare affari, con clienti della JV;
- l’obbligo dei venturers di non assumere dipendenti della JV;
etc.
Lo studio di fattibilità
Esaminiamo ora i principali steps dal punto di vista legale necessari per costituire una JV, contrattuale o societaria.
L’adempimento per realizzare una joint ventures è uno studio di fattibilità, che deve indicare:
- l’investimento complessivo, e come lo stesso verrà effettuato (capitale versato, conferimenti in denaro e in natura, i finanziamenti);
- i macchinari, la tecnologia ed il know-how che si intendono utilizzare;
- il mercato in cui opererà la JV;
- la durata della JV;
- il criterio di distribuzione degli utili;
- le stime del cash flow e del tasso di remunerazione del capitale e della redditività della JV;
- i costi per la formazione del personale.
La lettera di intenti o memorandum
Poi ci sono la lettere di intenti o un memorandum of understandingm, adempimenti che precedono la redaizione di un contratto vero e proprio.
Nella prassi, se correttamente utilizzati, la lettera di intenti e il memorandum sono accordi che le parti sottoscrivono per organizzare e regolamentare la trattativa che hanno avviato per la costituzione della JV, senza assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione all’effettivo perfezionamento del deal in corso di negoziazione.
Accordi principali e accordi accessori
La complessità di un’operazione di JV fa sì che generalmente la stessa non viene regolamentata con unico contratto, bensì con più contratti tra loro funzionalmente collegati, ovvero:
- un accordo principale (main agreement);
- una serie di accordi collegati (operational o ancillary agreements)
L’accordo principale di JV (main agreement) regolamenta condizioni, termini e modalità per la costituzione e la gestione comune della JV, individua gli obiettivi della JV, le azioni che questa dovrà intraprendere nel tempo in vista della realizzazione di tali obiettivi, e identificano le relazioni giuridiche che verranno ad instaurarsi tra ognuno dei venturers e la JV.
Indipendentemente dalla forma giuridica, il contratto principale di JV disciplina generalmente i seguenti aspetti:
- definizione di un obiettivo comune delle parti e valutazione dei rischi (giuridici, economici, commerciali) dell’intera operazione;
- la durata della JV (che potrà essere: illimitata con diritto di recesso in capo a ciascun venturer, spesso decorso almeno un certo periodo di tempo o al verificarsi di certi eventi), oppure limitata, eventualmente con rinnovo automatico salvo disdetta; può essere anche individuata una data (o accadimento) decorsa la quale (o verificatosi il quale) ciascun partecipante può chiedere la liquidazione della JV o avviare un processo di vendita dell’intero progetto).
- individuazione e divisione fra le parti dei rispettivi compiti (finanziari, operativi) nella JV;
- individuazione e divisione dei ruoli decisionali parti per la gestione della JV;
- individuazione di un’organizzazione comune di controllo e coordinamento delle prestazioni, al quale partecipano tutti i co-venturers (comitato direttivo o tecnico);
- individuazione di criteri per la partecipazione agli utili e alle perdite;
- limitazioni alla libertà contrattuale delle parti (clausole di confidenzialità, di divieto di concorrenza, di ripartizione dei mercati o comunque di non interferenza, etc);
- individuazione di cause di scioglimento del rapporto (con conseguente liquidazione della società, in caso di JV societaria);
- previsione di “vie di fuga” (exit strategies) che evitino la liquidazione della società ma allo stesso tempo impongano l’acquisto o la vendita delle quote dell’altra parte (sempre in caso di JV societaria).
Parallelamente al contratto principale di JV vengono quindi conclusi una serie di contratti operativi (ancillary o operational agreements), che disciplinano gli obblighi dei venturers rispetto alla JV.
Ad esempio, possono essere oggetto dei contratti operativi:
- contratti di finanziamento e relative garanzie reali e personali;
- contratti di appalto o accordi con i fornitori;
- lo statuto e i patti parasociali della JV;
- licenze di tecnologia o marchio;
- fornitura o concessione di prodotti, materie prime, strumenti o attrezzature;
Proprietà intellettuale
In sede di costituzione della JV, uno o più partecipanti potrebbero conferire marchi, brevetti, know-how o altri diritti di privativa, i quali divengono di proprietà del nuovo soggetto giuridico. In tal caso, in sede di liquidazione della società, il partecipante già titolare di tali diritti non ha diritto alla loro assegnazione ma avrà, al pari degli altri soci e in ipotesi di presenza di un attivo di liquidazione, un diritto di credito nei confronti della società.
In alternativa, se l’impresa partecipante ha interesse a vedersi re-intestare i diritti di privativa conferiti, il diritto di sfruttamento della proprietà industriale può essere oggetto di licenza alla JV, anziché di trasferimento in proprietà.
In tal modo, il venturer può continuare a sfruttare il marchio per la commercializzazione di prodotti diversi da quelli concessi in licenza alla JV, o in altri territori. Il venturer mantiene inoltre il controllo sul perseguimento e il mantenimento della registrazione della proprietà intellettuale ed è l’unico soggetto che può far valere i diritti di proprietà intellettuale contro i terzi.
Joint ventures societarie
Con il termine di JV societarie, come si è visto, si indicano forme di associazione temporanee di imprese finalizzate all’esercizio di un’attività economica in un settore di comune interesse, nelle quali le parti prevedono appunto la costituzione di una società di capitali, con autonoma personalità giuridica.
Nel caso delle JV societarie si ha dunque la nascita di una nuova società in cui lo schema societario assolve una funzione strumentale rispetto al sottostante accordo di JV, nel quale, in ogni caso, trova la sua fonte.
La JV societaria è generalmente costituita mediante la costituzione di una società con conferimento (o, più raramente, vendita) alla stessa da parte dei partecipanti di determinati beni (denaro, proprietà industriale, attrezzature, rapporti commerciali, etc.). Frequentemente, qualora i beni che i partecipanti intendono conferire siano già organizzati per l’esercizio di un’attività imprenditoriale, il conferimento ha ad oggetto un ramo di azienda, cosicché ogni impresa trasferisce un ramo di azienda a una società di nuova creazione, ricevendo in cambio le partecipazioni sociali, nella misura che sarà stata determinata nell’accordo di JV.
In alternativa, è possibile procedere a una fusione (propria o per incorporazione) delle imprese dei partecipanti, mediante la quale questi ultimi decidono, in via definitiva, di mettere in comune l’intera loro attività.
In entrambe le modalità di costituzione della JV, è opportuno valutare con attenzione il regime di responsabilità del nuovo soggetto giuridico così costituito per le eventuali passività pregresse dei suoi danti causa. Sia nell’ambito del conferimento di ramo di azienda (cfr. gli artt. 2112 e 2560 c.c.) sia nella fusione (cfr. art. 2504 c.c.), seppur con regimi e limiti differenti, il nuovo soggetto giuridico risponde infatti dei debiti dei conferenti o delle società partecipanti alla fusione.
Un contratto di JV societaria prevede tipicamente le seguenti pattuizioni:
- motivazioni che hanno spinto i venturers a costituire la JV, risultati che le parti si propongono di raggiungere specifici obiettivi assegnati alla JV;
- tipologia societaria della JV company, sede e denominazione, capitale sociale e quote di partecipazione dei singoli venturers, tempistiche e modalità di sottoscrizione del capitale sociale, contributi e relative garanzie offerte, eventuali condizioni al verificarsi delle quali è subordinato il closing e l’avvio delle attività della JV, rapporti che la JVCo instaurerà con i singoli venturers;
- criteri concordati tra i venturers per la gestione della JV (patti parasociali), ovvero: modalità e criteri per la convocazione, quorum e funzionamento degli organi sociali della JV, nomina e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione, criteri per la nomina dell’Amministratore Delegato e dei principali managers della JV, poteri e deleghe loro attribuiti, clausole poste a tutela del venturer di minoranza e identificazione delle decisioni che possono essere assunte dalla JV soltanto con il voto favorevole di entrambi i venturers, gestione finanziaria e amministrativa, politica dei dividendi, debt-equity ratio (indebitamento finanziario netto v. patrimonio netto) che la JV dovrà rispettare;
- risoluzione delle eventuali controversie tra i venturers in merito alle attività della società comune, e, nell’eventualità che il deadlock rimanga irrisolto, modalità per consentire l’uscita (exit) dei venturers, (opzioni put o call).
7. Organi della JV
Uno degli aspetti cruciali da regolamentare è quello relativo alla struttura e poteri degli organi sociali della JV company.
Le parti tendono spesso a organizzare la società di JV utilizzando una struttura di gestione a due livelli:
- da un lato, il consiglio di amministrazione, composto dal personale apicale di ciascun gruppo di partner di joint venture, con responsabilità primaria delle decisioni strategiche e altre decisioni materiali che può avere un impatto finanziario significativo sul futuro della JV;
- dall’altra parte, la direzione esecutiva con la responsabilità generale degli aspetti operativi quotidiani della JV e, che non è necessariamente composta in modo uguale, ma principalmente sull’esperienza del settore pertinente, sul know-how tecnico, sulle competenze e sulla rete locali.
Uno degli aspetti principali che deve essere disciplinato dal JV main agreement è il processo decisionale della JV in merito alle strategie ed alle singole operazioni che la JV societaria dovrà perseguire o compiere. La natura normalmente dinamica dell’attività produttiva ed economica delle imprese può infatti determinare la necessità di compiere scelte che, inizialmente, non erano prevedibili. Si pensi, ad esempio, ad una modifica legislativa del Paese in cui è stata costituita la JV, tale da comportare limiti alla distribuzione degli utili in favore di un socio oppure una diversa tassazione di tali profitti.
Spesso nel main agreement viene previsto, soprattutto a tutela dei venturers di minoranza, che determinate decisioni siano assunte non a maggioranza ma all’unanimità dei partecipanti oppure a maggioranza qualificata. Tra le materie straordinarie per le quali occorrono maggioranze qualificate o, addirittura, l’unanimità – oppure che attribuiscono a uno dei partner dei diritti di veto- rientrano solitamente mutamenti strutturali alla JV (ingresso di nuovi partecipanti, ampliamento dell’ambito di attività, varo di aumenti di capitale, liquidazione della società che incorpora la joint venture), la modifica del business plan, l’approvazione di investimenti e l’assunzione di indebitamento o il rilascio di garanzie superiori a determinate soglie, la costituzione di società partecipate, l’assunzione di top manager.
Sono a tal proposito frequenti le clausole statutarie o i patti parasociali che prevedono vincoli alla trasferibilità delle azioni (clausole di gradimento) e diritti di prelazione. Successivamente all’esercizio di eventuali diritti di prelazione, e in alternativa a clausole di gradimento, possono essere inseriti diritti di co-vendita (tag-along e drag-along), i quali consentono di aver adeguata certezza della sorte della propria partecipazione, indipendentemente dall’entità di questa.
Le clausole Tag-Along prevedono il diritto del socio a profittare delle condizioni ottenute dal socio di maggioranza in caso di vendita; il soggetto intenzionato a cedere la propria partecipazione potrà farlo a condizione di ottenere dal suo acquirente l’impegno all’acquisto delle residue quote alle medesime condizioni a lui riconosciute. Sono poste a tutela della minoranza, in quanto evitano al titolare del diritto di essere obbligato a diventare co-partner di terzi non graditi.
Le clausole Drag-Along attribuiscono invece al partner trasferente il diritto di obbligare quello non trasferente ad alienare al terzo anche la sua partecipazione, in tal modo, il socio cedente (di maggioranza) è in grado di meglio negoziare la vendita della società target avendo diritto di trasferire l’intero capitale sociale e quindi di evitare il possibile non gradimento del socio di minoranza da parte del terzo potenziale acquirente o comunque i poteri di veto esercitabili dal socio di minoranza
Nell’amministrazione ordinaria della JV sarà possibile prevedere deleghe gestionali con firme disgiunte, ad esempio fino a determinate soglie, prevedendo uno specifico budget e stabilendo chi si deve occupare dei singoli aspetti. È opportuno chiarire il peso decisionale spettante a ciascun partner, con approcci che possono oscillare tra un modello cooperativo (“una testa, un voto”), sino al sistema in cui un partecipante ha un peso preponderante a prescindere dalle quote che possiede giungendo al frequente caso in cui i poteri sono distribuiti in funzione dell’apporto di capitale relativo.
8. Dead-lock
A differenza di quel che accade nelle normali società di capitali, il vincolo societario rappresenta il mezzo, ma non lo scopo ultimo della JV, il cui presupposto essenziale (o almeno uno dei presupposti essenziali) è rappresentato dalla complementarietà degli apporti dei singoli venturer, ognuno dei quali, quand’anche in misura disuguale, è di solito indispensabile al buon esito delle attività della JV e più in generale al successo della JV.
Per tale motivo, spesso si prevede che contratto determinate decisioni possano essere approvate soltanto con il consenso del venturer di minoranza, quale che sia, quantomeno entro certi limiti, la sua partecipazione nella JV. In caso di disaccordo tra i venturers il rischio è che la necessità di una simile condivisione decisionale possa portare ad uno stallo (dead-lock) nelle attività della JV.
Lo stallo decisionale (dead-lock) si ha appunto quando, in mancanza del raggiungimento dell’unanimità (oppure di una maggioranza qualificata) nel consiglio di amministrazione della JV (alla quale partecipano i rappresentanti dei singoli venturers), la società non riesce ad adottare una decisione determinante per la prosecuzione dell’attività comune.
Sono frequenti le clausole statutarie, improntate ad una gradualità di misure, che mirano ad evitare che l’operatività della società sia bloccata dal dissenso di un co-partner su alcune decisioni operative importanti.
Si può prevedere ad esempio che ove i partners non siano in grado di risolvere l’impasse, in una prima fase si cerchi di raffreddare (cooling-off) la divergenza di opinioni, imponendo all’organo competente di riesaminare la questione controversa, dopo un nuovo approfondimento e sulla base di pareri e proposte di collaboratori o esperti esterni, ovvero portando la decisione ad un diverso livello decisionale (ad esempio, il CdA rispetto al comitato esecutivo; l’assemblea dei soci rispetto al CdA).
In una successiva fase si può prevedere che la decisione venga rimessa ad esperti, incaricati di trovare la soluzione più opportuna, con poteri decisionali o semplicemente propositivi (in tal caso, il buon esito è affidato alla capacità degli esperti di indicare una soluzione che convinca tutte le parti).
Vi sono inoltre diverse soluzioni adottabili per risolvere situazioni di dead-lock.
In base alla c.d. “move up clause”, in caso di dead-lock, uno dei venturer invia all’altro (o agli altri), una dead-lock notice, vale a dire, una comunicazione con cui si avvisano gli altri partecipanti della fase di stallo verificatasi nel CdA della JV. A questo punto si apre un dialogo non più tra i rappresentanti dei venturers in sede di CdA della JV, ma direttamente tra gli amministratori delegati dei venturers (o tra soggetti da questi individuati, oppure tra i legali rappresentanti delle imprese coinvolte nella JV), i quali coopereranno, nei tempi previsti dal main agreement, al fine di superare la fase di stallo e proseguire l’attività comune.
La cd “way out clause”, in caso di conflitto irrisolvibile, disciplina la cessione da parte di un venturer della propria quota di partecipazione all’altro venturer o agli altri venturers, prevedendo anche i criteri di liquidazione e tempi della procedura. A tal proposito sono frequenti le previsioni in base alle quali una delle parti ha diritto di vendere o acquistare la propria partecipazione (put/call option) in base a prezzi e modalità predeterminate.
9. Scioglimento della JV ed exit
Un altro aspetto importate è quello dello scioglimento della JV e delle possibili exit strategies. Soprattutto nei casi in cui venga costituita una JV con partners stranieri (investitori istituzionali o partner industriali), con il tempo l’apporto dei partners locali si può rivelare non adeguato, o le condizioni sopravvenute del mercato possono richiedere ai co-venturer un rinnovato e ulteriore impegno che alcuni (o tutti) non sono disposti a sostenere.
In questi casi, non è opportuno che la società venga messa in liquidazione, in quanto ciò comprometterebbe gli elementi economici rilevanti sostenuti. Il problema può essere risolto stabilendo una clausola di way out, che prevede e disciplina in modo vincolante, al ricorrere di determinate circostanze, l’uscita di uno o più soggetti dalla compagine dei partners che partecipano alla JV.
Più precisamente, tale clausola può regolamentare:
- l’uscita del partner nel cui favore la clausola sia predisposta; egli non sarà obbligato a trovare un terzo compratore, ma potrà cedere le proprie quote, ad un prezzo vincolato, agli altri partner, i quali si impegnano ad acquistarne la partecipazione (opzione put, ovvero proposta irrevocabile di acquisto);
- l’uscita del partner contro il quale la clausola sia predisposta; egli potrà essere costretto a cedere le proprie quote agli altri partner o a un terzo, ad un prezzo vincolato (opzione call, ovvero proposta irrevocabile di vendita)
Tali ipotesi possono essere e sono normalmente combinate, con facoltà di scelta attribuita alla Parte nel cui favore la clausola sia predisposta.