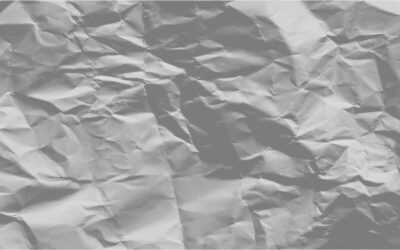Il reato di estorisione
L’estorsione, configurata dall’ordinamento giuridico italiano all’art. 629 del Codice Penale, incarna una delle figure delittuose contro il patrimonio, perpetrata mediante l’impiego di violenza o minaccia, al fine di costringere taluno a compiere, tollerare od omettere atti, con conseguente procurazione di un ingiusto profitto per sé o per altri, a danno della vittima.
L’elemento oggettivo del reato si identifica nella condotta coercitiva, che deve essere idonea e concretamente lesiva, in grado di indurre la parte lesa ad un comportamento contro la propria volontà. La minaccia o la violenza devono rivestire gravità tale da annullare il libero arbitrio del soggetto passivo, determinando un vizio del consenso che si traduce in un atto di disposizione patrimoniale o economica.
Sul piano dell’elemento soggettivo, il reato di estorsione richiede il dolo specifico, consistente nella consapevolezza e volontà di coartare la vittima mediante intimidazione o violenza, con l’intento di ottenere un profitto ingiusto. È essenziale che l’agente abbia la precisa finalità di arrecare un danno patrimoniale alla vittima, tramite l’alterazione della libertà decisionale e d’azione di quest’ultima.
Il delitto si considera consumato nel momento in cui l’agente ottiene il “profitto ingiusto”, indipendentemente dall’eventuale utilizzo o godimento dello stesso.
La sentenza della Cassazione
Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia di licenziamento, a ricoprire la carica di amministratore di una società da cui derivano rilevanti responsabilità e obblighi.
Pertanto la Cassazione, nella sentenza n. 7456 depositata ieri, ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 629 c.p. nei confronti del titolare di una società che aveva costretto un proprio dipendente a mantenere la carica di amministratore di una srl di cui il primo era socio e amministratore di fatto.
Nel caso di specie, il lavoratore era posto di fronte all’alternativa di accettare le condizioni imposte, (implicanti l’accettazione della carica di amministratore, pur rimanendo, in realtà, inalterata la sua posizione di lavoratore subordinato), dal datore di lavoro o di perdere il lavoro, risultando indifferente che tale evenienza si possa realizzare per una decisione “volontaria” del lavoratore o da un’iniziativa del datore di lavoro.
Inoltre, l’accordo era esclusivamente funzionale agli interessi dell’amministratore di fatto, che avrebbe fatto ricadere sulla persona offesa, le eventuali future responsabilità derivanti dalla gestione contabile, amministrativa e finanziaria della società (che è poi fallita).