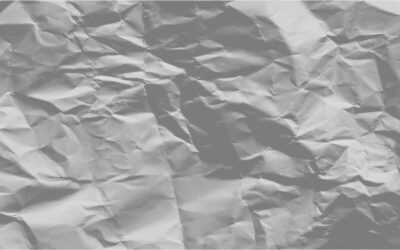L’amministratore di fatto, distinto dall’amministratore di diritto, è colui che prende decisioni e gestisce la società senza essere stato formalmente nominato attraverso una delibera assembleare o un atto di nomina conforme alla legge o allo statuto della società.
Secondo la giurisprudenza, gli elementi che caratterizzano la figura dell’amministratore di fatto sono:
- l’assenza originaria o sopravvenuta di una nomina formale;
- l’esercizio di funzioni riservate per legge o statuto all’amministratore di diritto;
- l’autonomia decisionale, che non deve necessariamente essere subordinata a quella dell’amministratore di diritto;
- il carattere sistematico e continuativo delle funzioni gestorie svolte, che non devono limitarsi a pochi atti eterogenei e occasionali (Cassazione, sentenza n. 27162/2018; Tribunale di Roma, sentenza n. 12474/2015);
- l’assenza di giustificazione per tali funzioni in base a un rapporto lavorativo subordinato o autonomo con la società, per cui l’interessato non deve essere in una posizione di subordinazione o soggiacere ai poteri direttivi dell’amministratore di diritto (Tribunale di Napoli, sentenza del 5 agosto 2015).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, con sentenza del 5 aprile 2024, quali sono gli “indici sintomatici” della figura dell’amministratore di fatto;
La prova dell’amministrazione di fatto può aver luogo attraverso la dimostrazione di;
- rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare
- la presenza di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in settori fondamentali dell’attività di impresa
- la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria.
Con la sentenza n.39732 depositata ieri, la Cassazione ha ribadito che, ai fini dell’attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto”, non occorre l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, bensì una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale.
Giova precisare che il caso esaminato concerne il socio accomandante di una società in accomandita semplice, che, per diposto dell’art. 2320 c.c, non può ingerirsi nell’attività amministrativa e gestionale della società, a meno di procura speciale per singoli affari.
Di norma, l’attività gestionale è riservata solo ai soci accomandatari della società in accomandita semplice.
Nel caso di specie, il ricorso aveva a oggetto la responsabilità del socio accomandante di una sas che, violando il divieto di immistione nell’attività amministrativa con ruolo gestorio, qualificato come durevole, continuativo e significativo, si era visto addebitare il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta ascritto all’accomandatario.
Sul punto, certamente rilevante è la presenza dell’imputato, anche come socio accomandante, all’atto gestionale dell’acquisto dell’azienda, momento iniziale e decisivo per la società oltre che coerente con l’oggetto sociale.
Parimenti, è parso come un’indebita immissione nella gestione societaria anche l’interessamento dell’imputato alle condizioni della successiva vendita del complesso aziendale, giustificato peraltro dall’imputato con la sua qualità di fideiussore della società.
E dunque, rileva e conclude la sentenza della Cassazione, la mancata estensione della dichiarazione di fallimento all’accomandante non ha precluso, di per sé, la responsabilità penale, a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta, del socio accomandante per aver violato il divieto di immistione nell’attività amministrativa della s.a.s